CS50 | Sociologia dei media, della comunicazione e della cultura
In una prima fase della rivista – negli anni Sessanta e Settanta – l’approccio sociologico ha dialogato sulla rivista con altri approcci, di tipo semiotico e filosofico, assecondando una felice tendenza degli studi sui media, la comunicazione e la cultura di quegli anni, secondo la quale l’oggetto e la sua scoperta prevalevano sulla specificità dei metodi di analisi.
Esemplari, da questo punto di vista, sono gli scritti di Umberto Eco (Il messaggio persuasivo, 3/1967), Gianfranco Bettetini (Realtà, realismo, neorealismo, linguaggio e discorso: appunti per un approccio teorico, 1-2/1974), Virgilio Melchiorre (Sul concetto di rappresentazione, 2/1979) e Francesco Alberoni (Società, cultura e Comunicazioni di massa, 1/1966). La tendenza continua anche nei primi anni Ottanta, per esempio con lo sviluppo del tema della relazione comunicativa da parte di Francesco Casetti (Cenni d’intesa, 3-4/1981).
La propensione al dialogo dialettico, ma aperto, si spinge in questi anni ad aprire un dibattito con voci esterne all’Ateneo e al comitato scientifico della rivista, ospitando anche autorevoli voci sia consonanti, sia dissonanti.
Negli anni seguenti, questa posizione dialogica è proseguita fino a fare della rivista una voce autorevole nel contesto degli studi internazionali di sociologia dei media e della cultura.
Fra i temi più sviluppati nel corso degli anni nella prospettiva sociologica se possono qui ricordare alcuni.
In primo luogo la ricerca sul pubblico dei media che si è espressa anche attraverso una particolare attenzione alla metodologia. Fino dagli anni Sessanta sono stati pubblicati articoli che, tra i primi, hanno riflettuto sugli approcci qualitativi allo studio della fruizione televisiva (Adriano Bellotto, Una esperienza italiana di ascolto collettivo di TV: i teleclub, 1, 1966 e Franco Rositi, Problemi e metodi dell'analisi di consumo, 1/1966). Nei decenni successivi sono stati approfonditi, in particolare, gli approcci etnografici (osservazione partecipante, interviste biografiche e in profondità) alle indagini sul pubblico dei media (Mariagrazia Fanchi, Mass-media e identità. Un modello di analisi, 4/1997 e Dallo spettatore implicito all'audience, 2/2001.
In secondo luogo gli approcci culturologici, capaci di legare i media ad alcune tendenze più generali nella trasformazione sociale, e in particolare della vita quotidiana (Chiara Giaccardi e Nicoletta Bosco, eds. Comunicazione e Vita quotidiana 3/2003 con saggi di Zygmunt Bauman e Fatema Mernissi).
In particolare sono stati affrontati il vissuto temporale e l’evolvere della dimensione spaziale (Fausto Colombo, Tempo, memoria, soggetto, 2/1981; Piermarco Aroldi, Tempo, Media e Identità, 4/1997; Piermarco Aroldi e Nicoletta Vittadini, eds, Attraversamenti. Spazialità e temporalità nei media contemporanei 1/2003 con saggi di Shaun Moores, Daniel Dayan, Claude Domenget).
Il tema della memoria (Govaertz, Memoria sociale, conoscenze e linguaggio nel processo sociologico di comunicazione, 4/1983, Paolo Jedlowski, Memoria individuale e memoria collettiva, 3/1999; Annalisa Tota, Memorie in conflitto, 3/1999).
La questione dell’identità individuale e collettiva (Chiara Giaccardi, Morfologie dell'identità. Note su un concetto frastagliato, 4/1997 e Anna Manzato, L'identità riflessa. Consumo, media e identità nei ‘Cultural Studies’, 4/1997).
Il tema del rapporto tra media e famiglia (Chiara Giaccardi, La famiglia sotto indagine, 1/1995; Dario Viganò, Famiglia e mass media, 1/1995; AAVV, Etica, comunicazione, comunicazione di massa, 4/1992).
La relazione tra media e minori (Barbara Scifo, Il “video patemico”: per un’analisi di «Amici», 2/1996; Pier Cesare Rivoltella, “Ospiti”, “invasori” e altri animali. Gli effetti della televisione sui minori, tra realtà e discorsi sociali, 2/1996; Marco Giarardo, “Cattiva maestra televisione”. Che cosa ha veramente detto Popper, 2/1999). Su quest’ultimo tema Comunicazioni Sociali ha dato voce non solo al dibattito internazionale, ma anche ai risultati di ricerche europee sul tema dei rischi e opportunità dell’uso di Internet da parte dei minori (Giovanna Mascheroni e Maria Francesca Murru, eds., Crescere online. Uno sguardo cross-culturale sui rischi e le opportunità di Internet per i minori in Europa 3/2009 ospitando i contributi dei più importanti studiosi del settore in Europa come Sonia Livingstone, Brian O’Neill, Leslie Haddon).
In terzo luogo l’innovazione tecnologica, affrontata in una chiave estranea ai determinismi tecnologici o economicistici, e attenta invece alle relazioni attive tra tecnologie, individui e società (Gianfranco Bettetini, Le attenzioni teoriche e operative ai nuovi media e alle nuove metodologie di analisi, 3-4/1986; Fausto Colombo, Nicoletta Vittadini, Maria Francesca Murru, eds. Critica della ragion socievole. Le teorie davanti alla problematicità del web 2.0 2/2012).
Si può rivendicare a Comunicazioni Sociali, da questo punto di vista, una particolare precocità nell’aver messo a fuoco, nel dibattito italiano e non solo, temi quali il videogioco e il suo rapporto con le dinamiche di sviluppo della persona e delle relazioni nella contemporaneità (Chiara Giaccardi, Videogames and Human Development. Research Agenda for the ‘80s. Considerazioni in margine, 4/1985); la video-comunicazione come linguaggio che caratterizza le società complesse e digitalizzate (Alberto Abruzzese, Videoarte e videocomunicazione oggi, 2-3/1992; Fausto Colombo, Arte video e mercato, 2-3/1992; Chiara Giaccardi, Mostrare il mostrabile, vedere l’invisibile: su alcuni caratteri del video come linguaggio, 2-3/1992); la trasformazione degli archivi; la Realtà Virtuale e le sue implicazioni rispetto all’esperienza e ai processi cognitivi (Nicoletta Vittadini, Realtà virtuale. L’ingresso nelle immagini, 3/1999); la Computer Mediated Communication, fino ai social media e al loro rapporto con le relazioni sociali tra individui (a cura di Nicoletta Vittadini, Dialoghi in rete, 1/2002).
Dal 2010, il tema dell’innovazione tecnologica è stato affrontato con una particolare attenzione alle problematiche antropologiche e sociali legate ad esempio alla dimensione “magica” dei media (Chiara Giaccardi e Simone Tosoni Media e Magia. Secolarizzazione dell’esperienza magica, usi magici dei media 3/2010 con saggi di Arpad Szakolczai e Annette Hill); alle forme di partecipazione civile e sociale delle persone attraverso la rete (Nico Carpentier e Maria Francesca Murru, eds., The responsibility of knowledge. The values of critique and social relevance in research on communication and culture3/2013 con scritti di Pater Dahlgren e Peter Lund) e alle caratteristiche del tecno-umanesimo (Chiara Giaccardi, ed. Being Humans, The Human Condition in the Age of Techno-Humanism3/2015).
Infine Comunicazioni Sociali ha dato voce alla riflessione sulla storia sociale dei media italiani, in cui la prospettiva prettamente sociologica si è incrociata con quella storiografica nella rilettura di alcuni periodi peculiari della vita italiana, e del ruolo in essa giocato dai media e dall’industria culturale (a cura di Fausto Colombo, Gli anni delle cose. Media e società negli anni Settanta, 1/2001) analizzando anche alcuni momenti cruciali dell’evoluzione del sistema dei media come l’avvento della televisione digitale (Mariagrazia Fanchi e Nicoletta Vittadini, eds. Incipit digitale. L'avvio della televisione digitale terrestre in Italia tra discorsi, prodotti e consumi 1/2008).
Chiara Giaccardi e Nicoletta Vittadini
Sommario »
Consulta l'archivio
Articoli Online First
Towards the Platformization of (Social) Media Memory: Articulating Archive, Assemblage, and Ephemerality
Ultimi 3 numeri
COMUNICAZIONI SOCIALI - 2024 - 3. Italian Cinemas and Moviegoing. Venues, People, Management
COMUNICAZIONI SOCIALI - 2024 - 2. BECOMING AGENS. Synesthetic and Active Processes of Image Reception in the Middle Ages
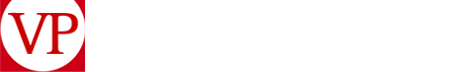










Articolo letto 2854 volte.
Inserisci un commento