Playing inclusion. The performing arts in the time of migrations: thinking, creating and acting inclusion

N. 1/2019 - A cura di Roberta Carpani e Giulia Innocenti Malini
La migrazione nell’età della globalizzazione è un dato strutturale. La presenza e la permanenza di quote crescenti di stranieri, per motivi di turismo, lavoro, studio, povertà o rifugio politico, suscitano una molteplicità di problematiche nei paesi di accoglienza, principalmente di carattere socio-culturale e politico. Scartando le due opposte opzioni estremiste (“accogliamoli tutti” vs “respingiamoli tutti”), le politiche migratorie dei diversi stati testano diversi modelli di convivenza, cittadinanza e coesione sociale. I principali sono l’assimilazionismo, l’integrazione, il multiculturalismo. Le crescenti reazioni xenofobe e populiste sono da mettere in relazione con l’insufficienza di questi modelli. Nel caso dell’assimilazionismo e dell’integrazione non si accettano e riconoscono le differenze culturali, per cui si vuole rendere l’altro simile a sé. Nel caso del multiculturalismo, invece, non si individua la possibilità di una qualsiasi unità e cooperazione. La prospettiva più convincente è quella dell’inclusione sociale. Nella definizione ideale di Jürgen Habermas, essa è l’apertura del soggetto, del contesto di vita, della comunità e dei servizi a tutti, anche e soprattutto a coloro che sono estranei e che lo vogliono rimanere. Quella di Habermas è una definizione teorica, astratta. Come si attua? Cosa succede nella pratica?
L’inclusione parziale dei migranti, quella che si attua in un solo settore della vita, come ad esempio nel mondo del lavoro oppure nell’ambito artistico o scolastico, produce problematiche analoghe agli altri modelli. È forse necessario pensare e praticare l’inclusione come un processo che innanzitutto mette in discussione gli aspetti della vita sociale, delle istituzioni e delle politiche. Un processo dinamico, instabile, in continua costruzione. L’inclusione non può essere vincolata a ruoli prescrittivi, a norme o costrizioni. Implica invece una continua costruzione e reinvenzione delle organizzazioni e dei contesti di vita, istituzionali e sociali. Il fine è dare un senso di appartenenza a tutti attraverso un processo di riconoscimento reciproco, in cui le ragioni, i legami, la vita di ciascuno si inseriscono in un percorso di crescita comune. L’inclusione è quel modo di vivere insieme che si fonda sulla convinzione che ogni individuo ha valore e appartiene alla comunità. Per questo l'inclusione non può avvenire solo nel mondo della scuola o del lavoro, ma deve contemplare tutti gli aspetti della vita, inclusi il gioco, i divertimenti, la partecipazione politica, la salute e l’ambiente.
La questione dell’inclusione, se osservata dalla prospettiva degli studi teatrali, rinvia al tema delle relazioni interculturali che ha attraversato il teatro fin dalle sue origini. Da un lato l’inclusione è da sempre tematica drammaturgica, dall’altro l’interculturalità sta alla base della dinamica teatrale stessa, intesa come co-costruzione dell’opera attraverso la relazione tra un attore e uno spettatore portatori di istanze e patrimoni culturali più o meno divergenti. Un’interculturalità, questa, che non ha però se non di rado prodotto effetti sulle politiche e sulle prassi sociali in una prospettiva di tipo inclusivo.
Prendendo le mosse da questa osservazione e dalle riflessioni esistenti, il volume intende indagare specificamente le risorse artistiche, sociali e politiche che le arti performative mettono al servizio dell’inclusione socio-culturale, facilitando processi collettivi di fronteggiamento partecipato delle complessità determinate dagli attuali movimenti migratori.
Posto questo obiettivo generale di indagine, il volume intende focalizzarsi in particolare su:
Gli argomenti posso includere, ma non sono limitati ai seguenti:
Scadenze e linee guida
Vi preghiamo di inviare entro il 15 maggio 2018 il vostro abstract e una breve nota biografica a redazione.cs@unicatt.it, a roberta.carpani@unicatt.it e a giulia.innocenti@unicatt.it. L’abstract deve avere una lunghezza compresa tra le 300 e le 400 parole (in inglese o in italiano). L’accettazione o meno verrà notificata via mail entro l’11 giugno 2018.
Se la proposta viene accettata, all’autore è richiesto di presentare l’articolo per intero entro il 15 settembre 2018. Gli articoli dovranno avere una lunghezza compresa tra le 4000 e le 5000 parole (in ogni caso non più di 35.000 caratteri, spazi e note inclusi). I contributi saranno inviati a due revisori, secondo la procedura del doppio-cieco, prima della decisione definitiva di pubblicazione.
La migrazione nell’età della globalizzazione è un dato strutturale. La presenza e la permanenza di quote crescenti di stranieri, per motivi di turismo, lavoro, studio, povertà o rifugio politico, suscitano una molteplicità di problematiche nei paesi di accoglienza, principalmente di carattere socio-culturale e politico. Scartando le due opposte opzioni estremiste (“accogliamoli tutti” vs “respingiamoli tutti”), le politiche migratorie dei diversi stati testano diversi modelli di convivenza, cittadinanza e coesione sociale. I principali sono l’assimilazionismo, l’integrazione, il multiculturalismo. Le crescenti reazioni xenofobe e populiste sono da mettere in relazione con l’insufficienza di questi modelli. Nel caso dell’assimilazionismo e dell’integrazione non si accettano e riconoscono le differenze culturali, per cui si vuole rendere l’altro simile a sé. Nel caso del multiculturalismo, invece, non si individua la possibilità di una qualsiasi unità e cooperazione. La prospettiva più convincente è quella dell’inclusione sociale. Nella definizione ideale di Jürgen Habermas, essa è l’apertura del soggetto, del contesto di vita, della comunità e dei servizi a tutti, anche e soprattutto a coloro che sono estranei e che lo vogliono rimanere. Quella di Habermas è una definizione teorica, astratta. Come si attua? Cosa succede nella pratica?
L’inclusione parziale dei migranti, quella che si attua in un solo settore della vita, come ad esempio nel mondo del lavoro oppure nell’ambito artistico o scolastico, produce problematiche analoghe agli altri modelli. È forse necessario pensare e praticare l’inclusione come un processo che innanzitutto mette in discussione gli aspetti della vita sociale, delle istituzioni e delle politiche. Un processo dinamico, instabile, in continua costruzione. L’inclusione non può essere vincolata a ruoli prescrittivi, a norme o costrizioni. Implica invece una continua costruzione e reinvenzione delle organizzazioni e dei contesti di vita, istituzionali e sociali. Il fine è dare un senso di appartenenza a tutti attraverso un processo di riconoscimento reciproco, in cui le ragioni, i legami, la vita di ciascuno si inseriscono in un percorso di crescita comune. L’inclusione è quel modo di vivere insieme che si fonda sulla convinzione che ogni individuo ha valore e appartiene alla comunità. Per questo l'inclusione non può avvenire solo nel mondo della scuola o del lavoro, ma deve contemplare tutti gli aspetti della vita, inclusi il gioco, i divertimenti, la partecipazione politica, la salute e l’ambiente.
La questione dell’inclusione, se osservata dalla prospettiva degli studi teatrali, rinvia al tema delle relazioni interculturali che ha attraversato il teatro fin dalle sue origini. Da un lato l’inclusione è da sempre tematica drammaturgica, dall’altro l’interculturalità sta alla base della dinamica teatrale stessa, intesa come co-costruzione dell’opera attraverso la relazione tra un attore e uno spettatore portatori di istanze e patrimoni culturali più o meno divergenti. Un’interculturalità, questa, che non ha però se non di rado prodotto effetti sulle politiche e sulle prassi sociali in una prospettiva di tipo inclusivo.
Prendendo le mosse da questa osservazione e dalle riflessioni esistenti, il volume intende indagare specificamente le risorse artistiche, sociali e politiche che le arti performative mettono al servizio dell’inclusione socio-culturale, facilitando processi collettivi di fronteggiamento partecipato delle complessità determinate dagli attuali movimenti migratori.
Posto questo obiettivo generale di indagine, il volume intende focalizzarsi in particolare su:
- L’integrazione fra teatro professionale e teatro sociale. Le due macro prospettive del teatro e del teatro sociale sono considerate tenendo conto delle rispettive specificità ma anche dei possibili scambi e delle possibili interazioni e contaminazioni. Infatti, è ormai evidente che il teatro contemporaneo, performativo e post-drammatico, guarda al teatro sociale e da esso prende modelli, prassi, processi, ipotesi di lavoro, con esiti molto differenti, che devono essere oggetto di attenta disamina critica e che dovranno essere adeguatamente valutati e storicizzati. Viceversa il teatro sociale, dopo aver cercato e individuato la propria identità, sembra ora aprirsi a più intensi scambi con il teatro professionale e sembra aver guadagnato una forte consapevolezza della sua possibile statura artistica, oltre che sociale. Ci sono poi esperienze teatrali che sovrappongono le due prospettive con esiti che presentano elementi di forte criticità e che necessitano di una riflessione sorvegliata e scevra da pregiudizi.
- La considerazione attenta dei diversi ambiti sociali su cui e con cui agiscono le due prassi teatrali. Nel caso del teatro sociale, l’azione teatrale coinvolge precisi gruppi disponibili a costruire diverse forme di elaborazione del vissuto comune e di progettazione delle nuove forme di cittadinanza. Nel secondo caso, il teatro della scena dei professionisti, allo stato attuale, si rivolge a fasce molto ampie di cittadini e può portare il tema della migrazione al centro dello spazio della rappresentazione dal vivo, un luogo cruciale in cui abbattere pregiudizi, correggere l’informazione distorta e propagandistica, costruire una reale conoscenza storica dei fenomeni attuali, ma anche di quelli del passato, riflettere sui diritti dei migranti e sulla loro identità giuridica. E, infine, può diffondere una cultura dell’inclusione che si radichi nelle azioni dei singoli, delle comunità e delle istituzioni.
- Un’indagine sulle arti performative realizzate da migranti, ritenendole forme di co-autoralità particolarmente significative ai fini dei processi di inclusione.
- La considerazione e lo studio dei processi di ideazione e di costruzione delle performances, poiché l’esito finale va considerato secondo logiche integrate con tutto il percorso culturale, sociale, antropologico che lo precede.
- Per quanto riguarda il teatro sociale, si richiede che i saggi proposti indaghino progetti che attraverso le arti performative e le pratiche festive abbiano messo in azione processi di inclusione sociale e integrazione, analizzandone e documentandone sviluppi, articolazioni, innovazioni, impatto sociale e culturale e capacità generative.
- Si privilegeranno i saggi dedicati a casi di studio che presentino innovazioni nella prassi, nei modelli, nei processi dispiegati; e quelli che invece approfondiscano le ragioni di debolezza o parziale efficacia di pratiche in corso.
- Si auspica che i casi di arti performative considerati comprendano prassi teatrali lungo tutto l’arco delle forme e dei linguaggi, dalla parola alla danza, ma anche prassi festive intese nell’accezione più ampia.
- Le azioni suggerite - pensare, creare, agire/rappresentare/recitare l’inclusione - sono parti di un unico processo di cambiamento sociale e politico a cui il teatro è oggi chiamato a dare un contributo determinante, secondo la sua originaria identità di arte politica, che cioè si prende cura della polis: la gradualità e l’intreccio del pensiero in primo luogo, - dove il pensiero è storia, analisi, progetto -, della creazione in secondo luogo, e infine dell’azione sono la prospettiva molteplice in cui i diversi gruppi di cittadini possono partecipare alla costruzione di una società inclusiva.
Gli argomenti posso includere, ma non sono limitati ai seguenti:
- Teatro/performance e l’etica dell’inclusione.
- Teatro/performance e le politiche dell’inclusione.
- Teatro/performance e le economie dell’inclusione: la sua istituzionalizzazione o de-istituzionalizzazione, la privatizzazione e la mercificazione.
- Performance tra etiche, politiche e attivismo.
- Forme e azioni dell’inclusione performativa.
- Il teatro a sostegno delle comunità inclusive.
- La migrazione e/o l’inclusione in relazione alle teorie della vulnerabilità, precarietà, difficoltà, sfruttamento; e anche in relazione a quelle della bio-politica, della governmentality e della sicurezza.
- Dall’estetica dell’inclusione all’azione dell’inclusione.
- Le estetiche della migrazione.
- Il teatro tra rappresentazione della migrazione e azioni sociali.
Scadenze e linee guida
Vi preghiamo di inviare entro il 15 maggio 2018 il vostro abstract e una breve nota biografica a redazione.cs@unicatt.it, a roberta.carpani@unicatt.it e a giulia.innocenti@unicatt.it. L’abstract deve avere una lunghezza compresa tra le 300 e le 400 parole (in inglese o in italiano). L’accettazione o meno verrà notificata via mail entro l’11 giugno 2018.
Se la proposta viene accettata, all’autore è richiesto di presentare l’articolo per intero entro il 15 settembre 2018. Gli articoli dovranno avere una lunghezza compresa tra le 4000 e le 5000 parole (in ogni caso non più di 35.000 caratteri, spazi e note inclusi). I contributi saranno inviati a due revisori, secondo la procedura del doppio-cieco, prima della decisione definitiva di pubblicazione.
Sommario »
Consulta l'archivio
Articoli Online First
“Scusi, chi ha fatto palo?”
Continuità e disruption del calcio su internet in Italia: dalle iptv ‘pirata’ a dazn
Towards the Platformization of (Social) Media Memory: Articulating Archive, Assemblage, and Ephemerality
Towards the Platformization of (Social) Media Memory: Articulating Archive, Assemblage, and Ephemerality
Ultimi 3 numeri
COMUNICAZIONI SOCIALI - 2025 - 1. Frameless Experiences. For a Multidisciplinary Approach to Immersive Media
COMUNICAZIONI SOCIALI - 2024 - 3. Italian Cinemas and Moviegoing. Venues, People, Management
COMUNICAZIONI SOCIALI - 2024 - 2. BECOMING AGENS. Synesthetic and Active Processes of Image Reception in the Middle Ages
COMUNICAZIONI SOCIALI - 2024 - 3. Italian Cinemas and Moviegoing. Venues, People, Management
COMUNICAZIONI SOCIALI - 2024 - 2. BECOMING AGENS. Synesthetic and Active Processes of Image Reception in the Middle Ages
Annate disponibili online
20252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973
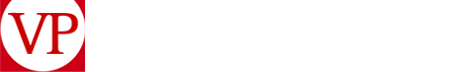










Articolo letto 2328 volte.
Inserisci un commento