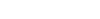Numero uno di "Comunicazioni Sociali on-line", pubblicato nel 2009 dalla rivista "Comunicazioni Sociali" e curato dal Dottorato di ricerca in Culture della Comunicazione, Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo.
SOMMARIO
di Massimo Scaglioni
pagine: 2
Scarica
Abstract ∨
Media e città: una relazione che, oggi più che mai, si carica d’interesse. Da un lato, i media ridefiniscono la propria spazialità, non solo rinnovando le affinità elettive con l’ambiente metropolitano, ma anche colonizzando nuovi territori e provando a riconfigurarli e rimapparli. Dall’altro lato, la città: uno snodo cruciale per reti e flussi, che includono i media come elemento cruciale e sempre più pervasivo. Alla relazione fra i media e la città abbiamo voluto dedicare questo numero d’esordio di «Comunicazioni Sociali on-line», proponendoci alcuni obiettivi che speriamo di aver conseguito. Media e città: una relazione che, oggi più che mai, si carica d’interesse. Da un lato, i media ridefiniscono la propria spazialità, non solo rinnovando le affinità elettive con l’ambiente metropolitano, ma anche colonizzando nuovi territori e provando a riconfigurarli e rimapparli. Dall’altro lato, la città: uno snodo cruciale per reti e flussi, che includono i media come elemento cruciale e sempre più pervasivo. Alla relazione fra i media e la città abbiamo voluto dedicare questo numero d’esordio di «Comunicazioni Sociali on-line», proponendoci alcuni obiettivi che speriamo di aver conseguito.
ZONA 1. MEDIA NELLA CITTÀ
di Miriam De Rosa, Glenda Franchin
pagine: 13
Scarica
Abstract ∨
Cosa vuol dire abitare? Come abitare? E soprattutto, quale il nesso tra questa nozione solo apparentemente elementare, i media e la città? La riflessione proposta si pone l’obiettivo di dare risposta a queste domande, per mettere in luce la posizione del soggetto nel momento in cui è chiamato a vivere nello spazio, a vivere lo spazio. In tal senso, proprio l’abitare sembra rappresentare una pratica significativa, poiché non solo chiama in causa la gestione dello spazio in senso architettonico, ma anzi si fa portatrice di un importante valenza filosofica e antropologica. In quest’ottica, analizzare il significato e le modalità dell’abitare consente di rendere conto dell’articolazione che l’uomo riverbera sullo spazio e delle dinamiche attraverso le quali questa strutturazione prende forma. Abitare significa infatti circoscrivere un territorio, stabilendo i confini di un mondo che il soggetto possa chiamare proprio, tracciare lo spazio in cui ci si trova per renderlo abitabile, curvandolo secondo le proprie esigenze e riducendo l’altro da sé all’appropriabile. Emerge così la distinzione tra spazio e luogo: il primo infinito e privo di connotazione, il secondo espressione di una singolarità, sua impronta e manifestazione. Ma se è vero che il luogo si configura come campo di un dominio e di un possesso, è altrettanto vero che esso è sempre e da sempre attraversato dal sopravvenire dell’Altro, cioè da tutto ciò che il soggetto non controlla e non può controllare. Lo spazio del soggetto, ovvero il mondo, è allora oltrepassato dal reale: è nell’incontro tra il territorio del “mio”, di ciò che è sotto controllo, e il sopravvenire di ciò che sfugge a ogni possibile dominio che si sedimenta il luogo. La riflessione sul luogo, inteso come scrittura che traccia la presenza di un esistente, permette di inquadrare l’abitare come territorio di intersezione tra la quiete di un possesso e l’inquietudine dell’esposizione al reale. È quanto risulta dalla riflessione finalizzata ad una fondazione dell’abitare. Una tale definizione di abitare offre l’opportunità di verificare come, su un piano più eminentemente pratico, sia possibile riconoscere una vera e propria pratica dell’abitare. È quanto si propone di mostrare l’analisi della mediafaçade allestita in piazza Duomo a Milano. Il grande schermo si presenta infatti come una sorta d’interfaccia, che funziona come elemento di disposizione dello spazio intorno al soggetto, originando un nuovo luogo attraversato da linee di forza. Questi vettori territorializzanti evidenziano la capacità del dispositivo rilocato di riarticolare lo spazio attraverso particolari dinamiche (riflessività, indessicalità, performatività, inclusività). Lo schermo diventa così un mezzo di riconfigurazione dello spazio della piazza che, curvato dall’esperienza del soggetto, assume le caratteristiche di un luogo, poiché in-formato sulla misura del proprio mondo. Il saggio si ferma sulla soglia di una topologia di traiettorie, corrispondenti ad altrettante tracce dell’abitare, suggerendo la necessità di proseguire lungo le due direttrici della fondazione e della pratica dell’abitare per esercitare un pensiero dello spazio non puramente geometrale, ma costitutivamente antropologico.
di Daniele Milesi, Sara Sampietro
pagine: 14
Scarica
Abstract ∨
Milano, pomeriggio di inizio estate. L’aria è calda, umida; soprattutto qui, sotto le volte della Stazione Centrale. Giovani interrailers chiacchierano seduti per terra, una ragazza sui vent’anni passeggia nervosamente avanti e indietro lungo la galleria dei binari, una signora distinta si ferma in edicola per cercare una rivista, una mamma parla al cellulare con suo figlio, un giovane uomo estrae il portatile e ne approfitta per terminare un lavoro urgente. Poi c’è chi mangia, chi fissa il tabellone degli orari, chi sbuffa e si irrita e chi si rilassa facendo le parole crociate. Alcuni passeggiano distrattamente, altri – impauriti e disorientati – si muovono circospetti; altri ancora, con passo deciso, si fanno strada verso il proprio binario. Azioni differenti che sottendono, a propria volta, interpretazioni molteplici e variegate di un comune orizzonte temporale: quello dell’attesa. Da questo punto di vista la Stazione Centrale può infatti essere definita come “lo spazio urbano dell’attesa”, il luogo cittadino che, forse più di ogni altro, incarna e circoscrive questa forma temporale. È a partire da questa considerazione che muove il presente intervento, e dall’ipotesi che proprio nella temporalità dell’attesa si inscrivano e si incardinino molteplici attività di consumo, mediale e non. L’indagine della Stazione Centrale si presta quindi come un’occasione per mettere a tema la relazione – reciproca e irriducibile – che, all’interno di un dato contesto, lega da un lato l’assetto e l’organizzazione temporale, dall’altro la configurazione delle pratiche di consumo. Si tratta, cioè, di rifiutare innanzitutto la prospettiva che, semplicisticamente, vede l’attesa come tempo morto, vuoto, inutile, tentando di esplorarne più a fondo la ricchezza fenomenologica e lo statuto interstiziale. Dall’altra parte significa esplorare la biunivocità di un modello che vede l’esperienza di attesa come condizione e risultante delle pratiche di consumo che in essa si realizzano: un tempo arredato e qualificato dalle attività fruitive e, complementarmente, un elemento che interviene nel dettare condizioni di possibilità e configurazioni di quelle stesse pratiche. La nostra riflessione si innesta nel solco di questa reciprocità tra contesto, forme dell’attesa e attività di consumo, avvalendosi di un impianto metodologico che mira a valorizzare sinergie tra strumenti desk (l’analisi del testo spaziale) e field (l’impiego di osservazioni etnografiche, interviste individuali e di gruppo) con l’obiettivo di indagare nel dettaglio vissuto e significati attribuiti dagli utenti della Stazione alla condizione dell’attesa e di ricostruirne il profilo esperienziale. Rispetto alle premesse iniziali l’indagine sul campo ha portato alla luce un panorama ricco, eterogeneo e complesso di contesti spaziali, forme di attesa e repertori di consumo. A questo quadro si aggiungono però anche considerazioni circa ostacoli e vincoli al consumo: uno spazio, quello della Stazione Centrale, che se da un lato stimola e accoglie una molteplicità e una varietà di pratiche fruitive, per altri versi sembra ostacolarne e inibirne altrettante, frustrando le richieste degli utenti e qualificandosi, in questo senso, come spazio di non-consumo.
di Luca Barra, Simone Carlo
pagine: 13
Scarica
Abstract ∨
Le città contemporanee sono spazi multisensoriali, multimodali, multimediali: i media invadono non soltanto le case, le tasche, le mani, ma anche le strade, le piazze, i centri commerciali, le zone dedicate a socialità e cultura, le stazioni. Questa invasione porta al moltiplicarsi non solo dell’esperienza visiva, ma anche di quella sonora. I mezzi di comunicazione personali e di massa che si inseriscono nel tessuto urbano stimolano sempre più una fruizione sinestesica. Tra loro, gli schermi di videocomunicazione diffusi in ogni spazio lasciato libero (o creato ad hoc) trasmettono in continuazione un flusso visivo e sonoro che si interseca con gli altri flussi di veicoli, di persone, di informazioni. Spesso, abbagliati dalle immagini in movimento, si tende a sottostimare l’importanza del sonoro e le conseguenze che la sua fruizione ha sul soggetto. Eppure proprio gli schermi, attraverso i loro dispositivi di diffusione dell’audio, riescono a modificare profondamente, a contaminare, talvolta persino a insidiare i paesaggi sonori nei quali vengono collocati e si trovano a operare. Il sonoro ambientale (voci, rumori, suoni della natura e della tecnica), l’audio personale (lettori Mp3, radio, chiacchiere, persino il sovrappensiero) e l’audio degli schermi si intersecano, lottano, convivono nella decodifica dei messaggi operati dai soggetti. Il suono rivela – ancora una volta – la sua natura malleabile e scivolosa, ma pure concreta e sempre presente, in una parola essenziale. E il soggetto fruisce del suono e instaura – in modo più o meno consapevole – un complesso rapporto con lo schermo, con le informazioni che trasmette, con il contesto in cui è situato, con le immagini e i frammenti percepiti. Uno degli spazi in cui maggiormente si sono concentrati gli schermi urbani – sia quelli (almeno parzialmente) informativi, sia quelli pubblicitari – sono le stazioni, ambienti di sosta e di transito per i flussi delle persone e delle merci. Su queste aree si concentra lo sguardo – e, soprattutto, l’orecchio – analitico: la Stazione Centrale di Milano, dove un loop continuo di spot si ripete nel frastuono ambientale, e le fermate della metropolitana milanese di Cadorna, Duomo e Centrale, dove “la tv della metropolitana” alterna news, programmi e pubblicità nel breve lasso di tempo tra un treno e il successivo. La mappatura delle fonti e dei testi sonori presenti nelle stazioni e l’osservazione – o meglio, una sorta di “auscultazione” – partecipante permettono di analizzare gli schermi urbani, così come i paesaggi sonori in cui sono inseriti e che contribuiscono a costruire. Rivelando che l’audio degli schermi – per quanto riguarda sia la programmazione, sia le modalità di fruizione – richiama un modello televisivo, quando non post-televisivo; e che le potenzialità del sonoro, in assenza di un’accurata progettazione, non sono sfruttate adeguatamente e finiscono spesso per risultare controproducenti rispetto ai fini comunicativi voluti.
di Marco Tomassini
pagine: 11
Scarica
Abstract ∨
Nello spazio urbano si concentrano da sempre le sedi e le principali campagne pubblicitarie outdoor di imprese e brand, nazionali e internazionali. Sempre lo spazio urbano ospita i più noti e articolati circuiti artistici istituzionali, le cui gallerie, i cui musei e le cui collezioni espongono opere di autori riconosciuti e legittimati al proprio interno. Tuttavia, è ancora lo spazio urbano ad assistere alla proliferazione e alla moltiplicazione di forme di creatività surrettizia, frutto di pratiche anonime e per lo più illegittime che si inscrivono direttamente sul suo “corpo”. Performance dal carattere effimero che fanno della città una scena e un supporto, potenzialmente rappresentando una riserva di spontaneità e originalità che sia attori del mainstream culturale ed economico, sia rappresentanti del mondo dell’arte “ufficiale” hanno interesse ad assorbire, per rinnovare la propria offerta e, spesso, connotare prodotti e marchi di valori trasgressivi e anticonformisti. Interesse che li porta non solo a servirsi delle estetiche di simili forme di creatività, ma anche, in molti casi, a mutuarne le pratiche e le tecniche illegittime, in netto contrasto con la loro trasparenza e il loro statuto legale. A loro volta, molti esponenti di questi mondi underground, prescindendo da istanze resistenti, sfruttano le opportunità concessegli da attori istituzionali e mainstream in vista della propria legittimazione presso il più ampio pubblico possibile. Una legittimazione che non si traduce necessariamente nello snaturamento delle peculiarità pubbliche e metropolitane delle loro opere, ma che piuttosto è finalizzata alla loro valorizzazione nel tessuto esterno della città, il solo contesto capace di esaltarne a pieno le potenzialità espressive. Questo sembra infatti il principale obiettivo di molti esponenti di quel variegato insieme di forme di creatività urbana cui, negli ultimi anni, si fa spesso riferimento attraverso la definizione di street art, la cui genericità è utile alla codificazione e alla qualificazione presso pubblici non specialistici di un oggetto le cui manifestazioni, altrimenti, risultano troppo disomogenee per essere comprensibili entro una cornice unitaria. Attraverso interviste di scenario ad alcuni dei suoi esponenti gravitanti nell’orbita di Milano, il saggio si è dunque concentrato sul fenomeno street art, affrontando il ruolo dello spazio urbano come territorio di confronto, contatto e commistione tra istanze e attori che è possibile definire “strategici”, e altri che possono invece dirsi “tattici”. Il riferimento va esplicitamente alla terminologia e al pensiero di Michel De Certeau, cui si è fatto ricorso nel tentativo di elaborare una cornice concettuale a un oggetto reso difficilmente leggibile dalla sua stessa, magmatica eterogeneità.
di Paolo Carelli, Claudia Giocondo, Maria Francesca Murru
pagine: 16
Scarica
Abstract ∨
C’è un momento, nel lento scorrere delle città e dei paesi di provincia, così come in quello frenetico e disseminato della metropoli, in cui lo spazio urbano assume i connotati di un grande palcoscenico adibito alla messa in scena di un particolare tipo di rappresentazione. È il momento elettorale, quello in cui la politica, elevata a piena identificazione con la sua manifestazione democratica più alta, ossia il voto, entra in contatto diretto con la città, sia nella forma del comizio nelle piazze che in quella del manifesto elettorale. In questi frangenti, e con particolare riferimento al secondo caso, le superfici esteriori, mobili o fisse, messe a disposizione dalle aree urbane, diventano luoghi deputati alla competizione politica, vere e proprie arene in cui si depositano e prendono forma il confronto tra i partiti e i rispettivi tentativi di legittimazione, negoziazione, riproduzione di contenuti e universi simbolici. Il periodo che precede un’elezione, di qualsiasi tipologia essa sia, si contraddistingue, quindi, per l’utilizzo di uno strumento comunicativo supplementare a quelli (i media vecchi e nuovi) che accompagnano e rappresentano la battaglia politica in momenti lontani dal suffragio. L’occupazione simbolica dello spazio pubblico effettuata in occasione della campagna elettorale rimanda a un’esigenza, che è propria della pubblicità, oltre che della comunicazione politica, di semplificare attorno a un selezionato nucleo di concetti e tematiche un complesso universo di valori, identità, credenze ideologiche e, finanche, appartenenze subculturali. Nei manifesti della campagna elettorale italiana per le politiche dell’aprile 2008, di cui in questo lavoro abbiamo analizzato alcuni esempi, il ruolo di chiarificatori e rivelatori del profondo sistema valoriale di riferimento è stato particolarmente palese, soprattutto in considerazione dei rilevanti mutamenti di denominazioni, simboli, alleanze che hanno interessato la maggior parte dei partiti italiani. L’approccio socio-semiotico, attento alla dimensione sintattica dei testi e ispirato alla distinzione di Landowski tra due modelli paradigmatici di intersoggettività, quello del “contratto” e quello dell’“acquisto”, ci ha permesso di leggere le scelte espressive dei partiti come segnali, non esaustivi ma certamente significativi, delle più ampie dinamiche di rappresentanza e rappresentazione immanenti all’agire e al comunicare politico. L’analisi ha evidenziato come le scelte di posizionamento fatte dai partiti nell’ultima campagna elettorale siano state dettate primariamente dall’esigenza di ridefinirsi rispetto ai valori e alle ideologie tradizionali di riferimento. In particolare, per quelle forze presentatesi agli elettori sulla base di universi simbolici consolidati nel tempo, la modalità del “contratto” ha prevalso come forma di capitalizzazione di un’adesione fiduciaria già conquistata; per i soggetti politici di nuova composizione, la logica del “contratto” si è invece combinata con quella dell’“acquisto”, facendo leva tanto sulla delega fiduciaria quanto sull’enunciazione puntuale di valori-prodotto da conquistare.
PASSAGGI
di Massimo Scaglioni, Anna Sfardini
pagine: 8
Scarica
Abstract ∨
Un maxi schermo al plasma installato in una qualsiasi stazione balneare nostrana è il punto di partenza di una riflessione sulla relazione tra televisione e spettatore al tempo della mobilità e della versatilità a cui la convergenza dei media l’ha destinata: lo schermo “da spiaggia” è solo uno dei possibili esempi con cui mostrare come sullo stesso (almeno in apparenza) medium si possano attivare frame di visione e di utilizzo assai diversi: per qualità, intensità, circostanze e finalità. La varietà e l’eterogeneità delle esperienze di fruizione televisiva che ne derivano non è però un frutto esclusivo della trasformazione tecnologica, ma piuttosto si va configurando come un inedito mescolamento di pratiche e usi consolidati con elementi innovativi, di rimediazioni e parziali spostamenti, di vecchio e nuovo, dove i fattori di continuità paiono pesare anche più di quelli di discontinuità. La tv in spiaggia “c’è sempre stata”, così come i frame ambientali, puntuali ed eventuali che si alternano nella vita estiva di uno stabilimento balneare o del bar sottocasa. I mutamenti più significativi legati alla digitalizzazione mediale sono da riscontrare altrove: l’indifferenza tecnologica dei nuovi device, che permette di considerare il televisore come il display di riferimento unico e adattabile per una varietà di fonti e contenuti mediali (la tv, il videogame, il videoclip musicale, il film eccetera); l’abbondanza di contenuto digitalizzato disponibile. È così che sulla “classica” esperienza di mobilità simbolica dello spettatore si innesta un’esperienza di mobilità tecnologica, intesa come accesso everytime/everywhere a un contenuto e come pratica di fruizione che si muove lungo percorsi multi-piattaforma. D’altronde, proprio il nesso mobilità/domesticità rappresenta, da sempre, l’aspetto più eclatante del medium, ossia la sua duplice articolazione in contesti domestici e extradomestici. Ciò che si modifica, allora, non è tanto la realtà del mezzo, quanto la realtà che, di volta in volta, circonda il mezzo, in quanto è il contesto specifico (sia esso spazio di transizione, luogo o territorio) che finisce per attribuire valore e funzione allo schermo e al suo contenuto. Alla ricerca, allora, il compito di esplicitare, di volta in volta, l’intenzionalità contestuale di uno schermo collocato in un dato luogo. Di guardare fuori dagli schermi.
di Simone Tosoni
pagine: 12
Scarica
Abstract ∨
Per un’analisi sociologica della contemporaneità è sempre più difficile esimersi dall’affrontare due grandi tematiche. La prima è quella dei media. In società ipermediatizzate praticamente ogni processo sociale, sia esso di tipo micro o di tipo macro, è infatti profondamente informato dai processi mediatici e comunicativi che lo innervano. La seconda è quella della città. I profondi processi di rescaling del sociale in atto vanno infatti restituendo centralità alle città, quali nodi di network globali plurimi (per esempio del lavoro, dei flussi finanziari, di popolazioni, della cultura) in cui il sociale stesso si va riorganizzando. In questo senso la città è tornata, come a inizio secolo, a essere uno dei contesti privilegiati per ossevare empiricamente i grandi processi sociali in atto. Nonostante tale doppia centralità, le discipline sociologiche hanno finora affrontato in modo piuttosto timido il tema congiunto di “media e città”. Nell’articolo, si tenta di dare conto della fecondità di tale oggetto di ricerca rileggendo, alla luce del tema dei media, le acquisizioni di una ricerca sul tema dello stato dei “quartieri sensibili” italiani, svolta tra il 2005 e il 2007. In tale ricognizione, il tema dei media e città emerge principalmente sotto cinque aspetti: a fronte della frammentazione dello spazio urbano della città postfordista, i media contribuiscono non solo alla zonizzazione urbana (“piegatura” del tessuto urbano), ma anche alla costruzione dello spazio simbolico dei territori zonizzati; la presenza mediale diffusa e i luoghi di consumo mediale (quali i cinema multisala) contribuiscono fortemente alla strutturazione interna dei territori, finendo spesso per aumentarne il livello di frammentazione; la presenza – o assenza – dei media diffusi (come la cartellonistica) e dei luoghi di consumo mediale costituiscono parte dei segni utilizzati dagli abitanti per monitorare l’andamento dei processi (per esempio, di peggioramento) che interessano il loro territorio; i media costituiscono un bacino di risorse simboliche e di modelli di convivialità attivamente rigiocati da cittadini e operatori nell’organizzazione di attività volte al sostegno della socialità e alla riappropriazione degli spazi urbani; appare una correlazione diretta tra alcune variabili (come la mobilità) che distinguono i diversi orizzonti di vita all’interno dei quartieri e il consumo mediale: variabili di solito poco frequentate nei modelli interpretativi classici sulla fruizione mediale. Senza pretendere di costituire una programma di ricerca esaustivo sul tema media e città, ciascuno di tali punti sembra aprire piste di indagine promettenti tanto per la sociologia della comunicazione e quella urbana quanto, nel momento in cui vengono intercettati più ampi processi di strutturazione sociale, per quella generale nel suo complesso.
ZONA 2. LA CITTÀ NEI MEDIA
di Cristina Tosatto
pagine: 9
Scarica
Abstract ∨
L’invasione di schermi non modifica solo l’aspetto dello spazio urbano. Forse si tratta di un fattore che scatena tutta una serie di modificazioni dell’assetto organizzativo spaziale, alterando proprio quelle relazioni che danno forma allo spazio. Ma cosa cambia? E quali sono gli elementi che si trovano invischiati nell’esplosione della multi-visione? Accade che il soggetto che si muove nello spazio urbano si adatti a vivere un’esperienza diversa della città: assiste alla sovrapposizione e intersezione di spazi visuali. E accade che questo tipo di esperienza molto spesso venga re-interpretata dal cinema contemporaneo, attraverso un processo che è stato definito di ri-spazializzazione. Allora non sembra assurdo pensare di avvicinare concettualmente lo spettatore urbano e lo spettatore cinematografico, entrambi alle prese con spazi in trasformazione dove tentano di ritrovare la propria collocazione. Si parte dal concetto di spazio sociale di Lefebvre, inteso come prodotto di relazioni tra “oggetti”, per arrivare a considerare il dispositivo come un produttore di spazio. Ecco che lo spazio urbano e lo spazio filmico si toccano nell’accezione di spazi mediali, in cui le dimensioni spazio-temporali perdono le proprie connotazioni a vantaggio di uno spazio in cui i confini tra i dispositivi si fanno sempre più labili e incorporei. Lo stesso processo di sgretolamento dei limiti si verifica in quel cinema contemporaneo che mette in scena tentativi di colonizzazione dello spazio filmico da parte di altri dispositivi. Un cinema che gioca con se stesso, consapevole del suo essere mezzo di rappresentazione di un mondo, interprete dei suoi cambiamenti. L’analisi di due film, Elephant di Gus Van Sant e Diary of the Dead di George Romero, prova a mettere in luce alcuni dei meccanismi della ri-spazializzazione, riflettendo sui processi di rappresentazione che oggi il cinema attua, guardando oltre i limiti della sala.
di Elisabetta Locatelli
pagine: 13
Scarica
Abstract ∨
Seguendo la riflessione di Gilles Deleuze, reale e virtuale non sono due aspetti contrapposti, ma entrambi concorrono a formare ciò che abitualmente esperiamo come la realtà. A livello meno teorico, il termine virtuale è stato applicato a tutti quei mondi che sono generati dall’interazione dell’uomo con particolari tipi di tecnologie che permettono di attualizzare eventualità inedite, come la realtà virtuale o gli ambienti di comunicazione che si trovano in rete. Fra le numerose intersezioni possibili fra reale e virtuale si è scelto di mettere a tema quella fra lo spazio urbano e lo spazio della rete, prendendo fra i tanti esempi possibili quello degli Urban Blog, tematicamente dedicati a un territorio specifico. Una prima intersezione fra i due territori avviene a livello semantico, nella misura in cui si cerca di comprendere un fenomeno nuovo, quello di internet e del web, attraverso concetti e categorie già posseduti. Un secondo modo in cui i due si possono intrecciare è il tentativo di mappare lo spazio oggettivo, misurabile della rete su base urbana, cartografando la disposizione dell’infrastruttura o degli utenti fisici. Più interessante è però l’analisi dello spazio soggettivo che si genera nell’esperienza della persona in rete, colta, in questo caso, all’interno degli Urban Blog. Si è spesso definito lo spazio della rete come liquido e deterritorializzato, ma l’evoluzione della stessa e degli usi nonché delle competenze degli utenti ha permesso di creare dei luoghi vivi, abitati e quindi sottratti alla dispersione del molteplice. L’analisi qualitativa di un campione circoscritto di Urban Blog dedicati alle città di Milano e Torino ha permesso di metterne in evidenza l’intersezione con il territorio urbano. La città trova spazio nel blog, in primo luogo, come oggetto di narrazione nei racconti dell’esperienza vissuta degli autori e dei commentatori, che aprono spesso spontaneamente il blog per poter parlare della propria città. Lo spazio in rete diventa anche una vetrina dove esibire le iniziative della città o un luogo di partecipazione dove poter prendere parte a quanto vi accade. Il legame con la città è, però, motivo di aggregazione anche all’esterno della rete. Al momento del diffondersi del blog in Italia, attorno agli anni 2003 e 2004, sorge infatti il desiderio fra i blogger di incontrarsi su base locale proprio per condividere la passione per il blog con chi abita poco lontano, e magari si frequenta in rete tutti i giorni, così come accade, in tempi più recenti, il fenomeno dei BarCamp, con il risultato di arricchire i legami offline e i discorsi e le relazioni in rete. Emerge però come una mancanza l’attivazione di mobilitazioni civiche grazie agli Urban Blog, che sembrano essere maggiormente dei luoghi di narrazione e di elaborazione della propria esperienza, a eccezione di quelli che si rivolgono a un territorio più circoscritto dove si rafforza la natura personale e locale del blog e i lettori possono sentirsi maggiormente coinvolti.
di Marco Muscolino
pagine: 7
Scarica
Abstract ∨
Dopo la campagna di Jour de fête (1949; Giorno di festa) e il mare di Les Vacances de Monsieur Hulot (1953; Le vacanze di Monsieur Hulot), nel cinema di Tati fa la sua comparsa il mondo urbano: dapprima in Mon oncle (1958; Mio zio), quindi in Playtime (1967; Playtime - Tempo di divertimento). Questi ultimi due film condividono un’analoga riflessione sulle trasformazioni socio-urbane figlie del boom economico che interessa, nel secondo dopoguerra, i paesi industrializzati – e particolarmente la Francia. Mon oncle mette in scena un paesaggio urbano diviso tra un passato ancora vivo e una modernità che avanza, simboleggiata dalla villa in cui la sorella del protagonista, Monsieur Hulot, vive con la sua famiglia. Con Playtime Tati conferma il suo gusto per il design urbano. Il regista ne inizia la “costruzione” sin dalla fine degli anni Cinquanta, dando avvio alla realizzazione di quella che viene subito battezzata Tativille: un’intera città ultramoderna costruita ex novo in una zona periferica di Parigi, facendo tesoro delle osservazioni che Tati annota mentre è in viaggio per il mondo durante la promozione internazionale di Mon oncle. Playtime diventa così, nel corso di un decennio, una sorta di kolossal in cui al posto della diva (o del divo) c’è una scenografia costosissima, fatta di strade asfaltate con tanto di semafori e insegne al neon, edifici abitabili e riscaldati (alcuni dei quali realizzati su piattaforme mobili per consentire di modificare parzialmente la topografia della città), scale mobili che attraversano l’interno di un aeroporto simile a quello di Orly, … In questa città invisibile Monsieur Hulot, nuovamente protagonista, vaga come un corpo estraneo, impermeabile ai cambiamenti di una modernità che ha ormai preso il sopravvento. L’analisi dei due film fa emergere l’estetica (l’idea di cinema) e la poetica (l’idea di mondo) di un regista capace di posare uno sguardo nuovo sulla città: uno sguardo che dà vita a una forma non tanto di cinema comico, quanto di “cinema della realtà”, i cui luoghi diventano spazi comici. Tati rappresenta situazioni perlopiù quotidiane, mettendo in scena le conseguenze che la modernità produce sui comportamenti sociali. La comicità è solo negli occhi di chi guarda (e nelle orecchie di chi ascolta). Mon oncle (Jacques Tati, 1958) [© Les Films de Mon Oncle / www.tativille.com]
di Andrea Fornasiero
pagine: 8
Scarica
Abstract ∨
Il poliziesco seriale televisivo americano è da sempre attento alla città dove è ambientata la serie, facendone una sorta di personaggio e delineandone sovente i lati più oscuri. Il 2002 segna l’inizio di due produzioni di questo genere dal taglio realistico, più di quanto si fosse mai visto fino ad allora in tv: The Shield e The Wire. Se la prima è ambientata nel quartiere verosimile ma immaginario di Farmington, la seconda presenta invece una mirabile aderenza ai luoghi di Baltimora e la fedeltà della rappresentazione è supportata dalle biografie dei suoi autori: David Simon, giornalista per il Baltimore Sun, quindi scrittore di libri inchiesta e infine produttore televisivo, e Ed Burns, poliziotto per oltre vent’anni, quindi insegnante e scrittore e sodale di Simon. I due collaborano per la prima volta a The Corner. A Year in the Life of an Inner-City Neighborhood, pubblicato nel 1998 e trasposto sullo schermo da HBO nel 2000 con la miniserie docufiction The Corner. In seguito al successo critico ottenuto, l’emittente mette in cantiere la realizzazione di The Wire, che unisce all’attenta osservazione della vita nel Westside di Baltimora un impianto da moderno police procedural drama, dove ha un ruolo di primo piano l’uso delle intercettazioni nelle indagini. Le aree rappresentate di Baltimora si fanno più numerose di stagione in stagione, allargando il ritratto della città fino a catturarne le molteplici sfaccettature, come pure le specularità e i tratti ricorrenti. Il primo comune denominatore a emergere è la povertà, che unisce le aree degradate degli spacciatori del ghetto con i distretti di polizia, incapaci di trovare ambienti decenti per gli uffici o di acquisire tecnologie adeguate alle indagini. Altro elemento ricorrente è il gran numero di abitazioni abbandonate, a causa del progressivo trasferirsi della popolazione nell’area extracittadina della Contea. Rimangono in città zone che sono come terre di nessuno, popolate da tossicodipendenti e flagellate dalla guerriglia urbana per il dominio dello spaccio di droga, ma in ultima analisi impossibili da controllare sia per i criminali sia per la polizia. La città attua piani di riqualificazione, ma pare limitarsi ad abbatterle, speculando poi su progetti edilizi successivi. Ha paradossalmente maggior successo, finché non intervengono le ruspe, il piano del capitano “Bunny” Colvin di adibire una di queste zone al libero spaccio di droga, per poter “salvare” il resto della città. La serie approfondisce quindi altri temi e descrive ulteriori zone della vita cittadina, dal porto piagato dalla disoccupazione alle scuole incapaci di formare i ragazzini, fino ai piani alti dell’informazione, nella redazione del Baltimore Sun, e della politica, con la campagna elettorale di Carcetti e i suoi primi anni da sindaco della città. Dunque uno sguardo a 360° che mostra l’influenza di Baltimora sulla vita dei suoi cittadini e fa della città del Maryland la vera protagonista della serie.
di Adriano D'Aloia
pagine: 15
Scarica
Abstract ∨
Suicidi, omicidi, incidenti, sfide sportive, voli supereroici, gag. Lungo l’intero arco della storia del cinema la rappresentazione della caduta del corpo umano dagli edifici della metropoli è una figura ricorrente e, quasi sempre, di grande impatto visivo ed emotivo. Con l’avvento della Modernità, l’uomo ha slanciato le sue creazioni (non solo architettoniche) verso il cielo, ingaggiato una sfida con i propri limiti e con la forza di gravità. L’altitudine e il volo, la vertigine e la velocità, l’ascesa e il crollo hanno trovato una declinazione anche nel cinema, medium designato a tradurre in immagine e suono quel desiderio di libertà e liberazione. Un desiderio che i terribili eventi dell’11 settembre 2001 hanno irrimediabilmente scalfito. L’immagine dei miserabili corpi delle persone che, di fronte all’unica possibilità della morte, hanno drammaticamente optato per quell’ultimo volo sono entrate con violenza nell’immaginario collettivo. Ma la natura di tale violenza immaginaria era già fatalmente presente nel cinema e nelle sue possibilità rappresentazionali. L’ambivalenza, anzi l’ambiguità, del desiderio umano insito nella caduta – libertà e liberazione, vitalità estrema e insuperabilità della morte – trova da sempre nel cinema un terreno di “messa in forma” concreta, ponendo lo spettatore di fronte a un’esperienza non solo sensoria, ma anche e ancor più sensibile. Un’esperienza cioè in cui non sono chiamate in causa solo le facoltà percettive e cognitive dello spettatore, ma anche la sua corporeità. In essa, gli elementi concreti legati alle condizioni spaziali e alla situazione percettiva, intersecati con gli elementi audiovisuali simbolici e con i processi cognitivi di comprensione della narrazione, sono intimamente correlati agli aspetti poetici e patemici. Nel suo complesso, l’esperienza filmica coinvolge due sfere della corporeità sensibile: il motorio e l’emotivo. Nel solco tracciato dalla fenomenologia (da cui hanno attinto la psicologia sperimentale, la filmologia e per alcuni aspetti il cognitivismo), la teoria del cinema ha recentemente cominciato a interessarsi con maggiore rigore e sistematicità al ruolo del corporeo e del sensibile nell’ambito della ricezione filmica, in linea con la tendenza degli studi semiologici a concentrarsi sugli aspetti esperienziali (e non più segnici e testuali) delle pratiche umane di significazione e comprensione della realtà e dei prodotti mediali. Al contempo, i progressi nel campo delle neuroscienze – in particolare la scoperta dell’esistenza e dell’attività dei “neuroni specchio” nel cervello umano – stanno contribuendo ad affermare la natura intuitiva e pre-riflessiva dei processi di imitazione motoria e di compartecipazione emotiva. L’empatia, concetto ambiguo sin dalle sue origini (nel campo dell’estetica e della fenomenologia), sembra essere stato elevato a “strumento unico” di comprensione ed esplicitazione delle pratiche di condivisione dell’esperienza. Eppure, per quanto da sempre presente nelle implicazioni filosofiche delle teorie filmiche di matrice psicologica, il modello empatico è stato sostanzialmente respinto dal cognitivismo, perché considerato troppo “riduttivo” o non necessario alla spiegazione dei processi di coinvolgimento emotivo dello spettatore (soprattutto rispetto al personaggio). Se la rappresentazione cinematografica della caduta del corpo umano nello spazio vuoto costituisce un ottimo esempio di “messa in forma” della relazione fra il corpo proprio e il corpo rappresentato, allora vagliare la tenuta della nozione di empatia nell’ambito dell’esperienza filmica può rivelarsi una buona strategia per capire in che modo lo spettatore fa esperienza della relazione con l’Altro, con il mondo e con il Sé.
di Andrea Gelpi, Matteo Tarantino
pagine: 13
Scarica
Abstract ∨
La rivolta della comunità cinese in via Paolo Sarpi a Milano il 12 aprile 2007 ha prodotto una frattura sociale tale da suscitare un interessamento sia dei media tradizionali, voci istituzionali, sia dei media minori, locali e diasporici. La necessità di tematizzare un evento traumatico inconsueto e inaspettato, almeno per quanto riguarda la cittadinanza milanese, ha palesato diverse posture enunciazionali all’interno delle trattazioni offerte dai media. In mezzo alla polifonia di tutte queste voci, si è assistito alla nascita di un prodotto informativo “ibrido” che manifesta tutta la schizofrenia divulgativa che ruota intorno alle tematiche della migrazione, soprattutto da un punto di vista contenutistico e linguistico. Il notiziario bilingue Chinatown Today non rappresenta una voce fuori dal coro, anzi diventa il paradigma per comprendere alcune dinamiche in gioco nel panorama dell’editoria multiculturale o comunitaria. L’interesse perfino dei grandi editori e degli inserzionisti nei confronti di nuovi prodotti mediali multiculturali, e il tentativo consecutivo di appropriarsene all’interno delle grandi testate attraverso un attento lavoro di rimediazione linguistica ed estetica, segna una nuova tendenza in atto nella produzione giornalistica finalizzata alla fidelizzazione di nuovi pubblici presenti sul territorio italiano: i migranti. Il paradigma in realtà disvela qualcosa di più profondo. La rinuncia della comunità Cinese di Milano al dialogo con le istituzioni si traduce in assenza di forme di auto-rappresentazione della comunità stessa. L’evento traumatico avvenuto nel quadrivio milanese ha imposto ai migranti, come di consueto, una presa di posizione dialogica per instaurare un canale di comunicazione conciliante, ma soprattutto in grado di rassicurare la cittadinanza autoctona. La peculiarità del carattere cinese porta alla rinuncia all’istanza di auto-rappresentazione, cioè di una identificazione che parta dal dentro. Davanti al rifiuto di raccontarsi, le istituzioni italiane dispiegano una serie di dispositivi mediali in grado di colmare una deficienza strutturale della società. Così Chinatown Today, sotto le mentite spoglie del notiziario etnico, si infiltra negli anfratti della comunità con la pretesa di restituire al pubblico una narrazione “in prima persona” del microcosmo di Chinatown. L’operazione discorsiva del prodotto mediale risulta viziata da un uso delle grammatiche affini a un certo tipo di produzione multiculturale, che stridono cacofonicamente con i contenuti contaminati da una prospettiva etnocentrica. L’articolo, dopo un breve excursus teoretico sullo sviluppo di nuovi oggetti sociali nel mediascape contemporaneo, quali i media diasporici e i media multiculturali, analizza il tentativo mistificante di una voce semi-istituzionale che vuole ripristinare un dialogo tra la comunità cinese e le istituzioni milanesi dopo la frattura, ossia il tentativo di risolvere un curiosa anomalia che ostruisce la via della pacificazione. In realtà, l’artificiosità di un’“auto”-narrazione, proveniente dal basso, amplifica problematiche a tutt’oggi irrisolte. Nella sua pochezza contenutistica, Chinatown Today risponde al tentativo di una mediazione mediatizzata del conflitto, una diplomazia attraverso il video, dove il medium diventa il messaggio, sì, ma di riconciliazione apparente: il paciere in grado di ristabilire una “tranquilla percezione” della realtà di via Paolo Sarpi.
|
|